martedì 28 ottobre 2025
San Marco: si presenta il progetto alla città
sabato 27 settembre 2025
Semi di pace e di speranza
lunedì 22 settembre 2025
Di uomini così, ne nasce uno ogni mille anni
Di uomini così, ne nasce uno ogni mille anni. Duemila anni fa abbiamo avuto Gesù. Nel millennio precedente avevamo avuto Buddha. Nel millennio successivo abbiamo avuto san Francesco. Vedremo cosa ci attende ora, in questo millennio appena cominciato. Che, se non daremo retta a san Francesco, se non seguiremo il suo amore per la natura e il suo rispetto per la dignità umana, potrebbe essere l’ultimo.
Francesco e Buddha
La storia di Gesù è nota. La raccontano i Vangeli, peraltro non così letti come crediamo che siano. La storia di Buddha è stata narrata in molti testi e scolpita nella pietra di Borobudur, sull’isola di Giava. Borobudur è un tempio alto come una montagna: forse il luogo che più mi ha colpito al mondo, insieme con gli splendidi affreschi di Cimabue e del suo allievo Giotto nella basilica di San Francesco ad Assisi. La grande differenza è che ad Assisi c’è il vero volto di Francesco, il ritratto che vedete sulla copertina di questo libro. E c’è il suo corpo: nascosto, ritrovato, venerato. A Borobudur non c’è il corpo di Buddha, che fu arso sulla pira funebre. E vengono raccontate non una, ma molte storie: perché Buddha non è uno solo, così come il nostro tempo, il nostro mondo non è l’unico. Secondo il buddhismo, molti mondi si sono succeduti e si succederanno; e ognuno ha avuto il proprio Buddha. Il Buddha «storico», quello del nostro tempo, era un principe. Si chiamava Siddharta Gautama, era figlio di un sovrano che regnava sull’attuale Nepal, alle pendici dell’Himalaya. E la sua storia ha sorprendenti punti di contatto — oltre a ovvie differenze — con quella di Francesco(…).
Siddharta è il Buddha «storico», il nostro Buddha; ma prima di lui ne sono vissuti molti altri, e anche le loro storie sono in parte raccontate a Borobudur. C’è un bassorilievo che mi ha colpito in modo particolare. Raffigura un re nel suo palazzo. Dalla finestra entra un passero, inseguito da un falco. Il passero si rifugia presso il re, che lo prende sotto la sua protezione. Ma il falco protesta: per salvare il passero, il re condannerà a morte lui, destinato a morire di fame. Colpito, il re offre al falco il proprio stesso corpo: si taglierà la quantità di carne pari al peso del passero, e la darà in cibo al falco. Ma prodigiosamente la carne del re, posta sulla bilancia, non eguaglia mai il peso dell’uccellino. Alla fine il sovrano, per salvare sia il passero sia il falco, dovrà sacrificare se stesso. Per evitare che altri muoiano, sarà lui a morire. Proprio quel supremo gesto di amore, di bontà, di carità farà di lui un Buddha: l’illuminato, il risvegliato, il salvato dal ciclo delle rinascite e quindi dalla schiavitù del dolore. A noi cristiani viene in mente il sacrificio di Gesù sulla croce, e anche la carne martoriata di san Francesco: l’amore che vince su ogni cosa, pure sul dolore e sulla morte (…).
Siddharta è il titolo di un libro di enorme successo di Hermann Hesse. Meno noto è che Hermann Hesse abbia dedicato un libro anche a san Francesco. È un libriccino breve, ma prezioso. Perché ci fa capire l’eccezionalità di Francesco. Proprio come quella di Buddha e di Gesù. Francesco, scrive Hesse, fa parte di quelle straordinarie creature che «hanno portato Dio vicino a tutti gli uomini e hanno restituito nuovamente valore al mistero della creazione». Creature che «si ponevano nude di fronte alla terra e al cielo, come se fossero stati i primi uomini, mentre noialtri riteniamo di poter vivere solo nell’involucro di sicure rappresentazioni e di abitudini acquisite». Non è meraviglioso? Francesco, come Gesù, come Buddha, si spoglia di se stesso, e si pone nudo davanti al mondo; come se fosse il primo uomo, il nuovo Adamo, un altro inizio per l’umanità. Nudo non in senso metaforico, ma letterale. Francesco si spoglia nella piazza del suo paese, tra lo scandalo e l’incredulità generale. Non soltanto restituisce i suoi vestiti al padre; rinuncia a essere suo figlio. Il suo vero padre è Dio; per questo lui è l’alter Christus , un altro Gesù. Per questo chiama fratelli e sorelle tutte le creature: il sole, le stelle, la luna, il vento, il cielo, le nuvole, i frutti, i fiori. Tutti gli elementi: l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco. E tutte le avversità: la malattia, il dolore, financo la morte.
I crociati e gli eretici
San Francesco visse in un tempo grandioso e terribile. Il tempo dell’imperatore Barbarossa, che nel 1176 era stato sconfitto dai milanesi e dai loro alleati del Nord Italia, e di suo nipote Federico II, che si innamorò del Sud e fu chiamato Stupor Mundi, stupore del mondo. Il tempo di Saladino, che riconquistò Gerusalemme, e di Gengis Khan, che devastò l’intero Oriente e morì meno di un anno dopo Francesco. Il tempo in cui Fibonacci fa risorgere la matematica in Occidente, individuando una sequenza di numeri presente in molte forme naturali; mentre in Sicilia Cielo d’Alcamo getterà, pochi anni dopo Francesco, le fondamenta della nostra letteratura, scrivendo anche lui versi nella lingua del popolo. Il tempo di Papi potenti e spietati, che erano i veri sovrani d’Italia e tenevano testa all’imperatore. Il tempo in cui vengono gettate le fondamenta del mondo moderno. San Francesco visse nell’epoca delle città e delle università. L’epoca in cui comincia a circolare molto denaro, in cui vennero inventate le banche, la finanza, la borghesia; e Francesco, prima di scegliere la povertà, apparteneva a una famiglia ricca, alla nuova classe sociale che si era elevata dalla massa dei contadini senza disporre dei privilegi della nobiltà: appunto, la borghesia. Era l’epoca in cui si eressero cattedrali dalle guglie lanciate verso il cielo e dalle grandi vetrate inondate di luce. L’epoca delle crociate e degli eretici. San Francesco partecipò a una crociata, ma non per uccidere infedeli; per convertirli, o per cercare il martirio. E san Francesco rischiò di essere bruciato come eretico.
C’era nella sua santità una vena di follia. E non soltanto perché parlava con le piante e con gli animali (e aveva una particolare venerazione per gli uccelli e per gli agnellini). Ma perché rifiutava i vestiti, il cibo, una cavalcatura, un letto. Abbracciava i lebbrosi. Si lasciava picchiare, ferire, umiliare dai prepotenti. Non aveva alcuna ambizione se non quella di servire. E confondeva i ricchi mettendo loro in mano monete d’oro.
La nascita del capitalismo non poteva che creare una reazione. Finiva il tempo dell’economia di corte, chiusa, agricola, segnata dallo scambio e dal baratto, e iniziava un tempo nuovo in cui in poche mani si accumulavano enormi ricchezze, senza alcuna forma di redistribuzione che non fosse la carità. Tutto questo generò scontento e inquietudine, che presero a volte la direzione della rivolta, altre volte quella della rinascita spirituale. Proprio in quel tempo di Papi sempre più potenti e di mercanti sempre più ambiziosi, crescevano indomabili la volontà di giustizia, l’aspirazione alla povertà, l’ansia di riscoprire il Vangelo, il sogno di vivere come Gesù. Sorgevano profeti, veggenti, penitenti. Alcuni pagarono quel sogno con la vita. San Francesco seppe metterlo al servizio della Chiesa e della sua possibile rinascita. Era animato da un’energia indomabile, da una forza di ribellione, da una «violenta sete di infinito e di eterno».
San Francesco era determinato sin dalla giovinezza a fare qualcosa di eroico, di nobile, di grandioso, che fosse davvero all’altezza della sua epoca; finì per fare qualcosa di eterno, che l’avrebbe proiettato al di fuori del tempo, lontano dai limiti di tutto ciò che si disintegra, si corrompe, si consuma, sino ad arrivare, intatto e anzi più forte che mai, ai giorni nostri. Quando finalmente, dopo otto secoli, è sorto un Papa di nome Francesco. E dopo di lui è venuto un Papa che ha scelto il nome dell’amico del cuore di Francesco: Leone.
Perché è il primo italiano
La celebre definizione di san Francesco — «il più italiano dei santi» — viene attribuita di solito a Mussolini, oppure a Papa Pio XII. In realtà è di Vincenzo Gioberti, che scrisse Del primato morale e civile degli italiani , un’opera che all’inizio del Risorgimento restituì orgoglio ai nostri compatrioti, ai nostri antenati, negli anni in cui l’Italia unita non era che un sogno. E Gioberti definisce Francesco «il più amabile, il più poetico e il più italiano de’ nostri santi». In un primo tempo avevo pensato di usare questa espressione come sottotitolo del libro. Poi ho preferito quella che avete letto: il primo italiano. Non è una citazione. Non appartiene a nessuno. Me ne assumo la responsabilità. Consapevole che sarà molto criticata. San Francesco non si è mai definito italiano. Non ha mai parlato di Italia. Il suo scenario era Assisi, e il mondo. Ma, se è per questo, neppure Dante, che invece di Italia parla moltissimo, la pensava come uno Stato, o una nazione. Del resto, il concetto attuale di Stato, di nazione, di patria è un’invenzione dell’Ottocento. Quando Sancho Panza torna a casa con don Chisciotte dopo mille pagine di peripezie, si inginocchia a benedire la patria, il luogo dove ci sono i suoi morti e i suoi ricordi: che era appunto il paesello della Mancha, non la Spagna, al tempo un’espressione geografica (c’era l’impero, e c’era una monarchia assoluta), proprio come l’Italia.
Eppure credo che Francesco possa davvero essere considerato il primo italiano. Non è una tesi scientifica. È un’adesione spirituale. Un moto dell’anima. San Francesco è il primo italiano perché è una figura fondamentale, anzi fondativa, della nostra identità. E non perché oggi è il patrono d’Italia. Quella è solo una conseguenza. Francesco è il primo italiano perché è il primo a scrivere una poesia meravigliosa, il Cantico delle Creature, nella nostra lingua: il volgare, la lingua del popolo, l’antenato dell’italiano moderno. Francesco è il primo italiano perché nacque, morì e fu sepolto nel cuore della penisola, abitò i luoghi più segreti e ameni dell’Italia centrale, e per l’Italia viaggiò, nelle città e nei boschi, a Firenze e nei romitori, a Bologna e nei santuari di montagna. Perché ha inventato il presepe vivente, matrice dei grandi presepi custoditi nelle chiese e dei tanti piccoli presepi che sono in ogni casa, in ogni famiglia italiana. Perché, comunicando il Vangelo attraverso la parola, la musica, il mimo, il gesto, ha consentito lo sviluppo del teatro e delle rappresentazioni. Perché ha ispirato i più grandi italiani della storia: sono stati terziari francescani, quindi appartenenti al suo ordine sia pure da laici o da sacerdoti, Giotto, Dante, Petrarca, Boccaccio, Tasso, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci, forse anche Galileo Galilei, di sicuro Alessandro Volta, Luigi Galvani, Guglielmo Marconi, Alessandro Manzoni, don Bosco, fino ad Alcide De Gasperi. Perché per primo, incarnando il Vangelo, ha sostenuto non solo a parole ma con l’esempio che tutti gli uomini nascono liberi e uguali, e che tutti siamo uguali davanti a Dio. Perché ha riconosciuto la dignità a ogni essere umano. Ha trattato le donne da pari a pari. Ha amato e difeso i bambini, in un tempo in cui erano considerati adulti più piccoli. Si è preso cura dei malati, dei deformi, dei lebbrosi, delle persone ai margini della società. E così ha posto le fondamenta della lettura italiana del cristianesimo: una fede non incompatibile con la ragione, incentrata non solo su Dio ma anche sull’uomo, capace di dialogo e di rispetto verso gli altri popoli e le altre religioni, che è poi l’essenza dello spirito di Assisi.
Francesco è il primo italiano perché è il precursore dell’umanesimo, che è il grande contributo dato dall’Italia alla civiltà universale.
Francesco è il primo italiano anche perché, riscoprendo il creato, lodando la natura, parlando agli animali, proclamando che ogni cosa è nostra sorella, ha cambiato la nostra visione del mondo. E ha ispirato generazioni di artisti. Ha restituito vita all’arte. Ha indotto i pittori a sostituire il fondo oro con il paesaggio. Prima i santi erano dipinti come se fossero già in Paradiso, circonfusi di luce, in una dimensione astratta, eterea, distanziante. San Francesco viene raffigurato in mezzo alla natura, sempre circondato da piante, animali, profili di montagne, cieli pieni di nuvole; così lo spettatore diventa parte dell’opera. Noi che guardiamo siamo lì, accanto a Francesco, con lui, e quasi lo ascoltiamo parlare. Per questo possiamo considerare eredi di Francesco anche i più grandi artisti del Trecento, Giotto nella pittura e Dante nella parola.
Giotto e Dante
Giotto ad Assisi ha costruito quello che per secoli sarebbe stato l’immaginario del santo. Dante lo adorava. Frequentava la chiesa dei francescani fiorentini, Santa Croce. E gli dedicò versi meravigliosi: «Del suo grembo l’anima preclara/ mover si volle, tornando al suo regno/ e al suo corpo non volle altra bara». San Francesco volle essere sepolto nella nuda terra. Come Papa Francesco. E il grembo da cui, secondo Dante, la sua anima luminosa si mosse per salire in cielo è quello della donna amata: la povertà.
La povertà non fu certo inventata da san Francesco. Al suo tempo la maggioranza degli esseri umani era povera; e nessuno può capirlo meglio di noi, nati al tempo del trionfo della borghesia e della classe media, e vissuti al tempo del suo impoverimento. Ma Francesco dimostrò che la povertà può essere non soltanto imposta e subìta, ma scelta, accettata. E se sarebbe disumano che tutti volessimo essere poveri, tutti possiamo capire che non siamo al mondo solo per guadagnare denaro, assegnare bonus milionari ai manager che licenziano, trafficare in bitcoin, fare soldi con altri soldi, e portarli nei paradisi fiscali.
Francesco il primo italiano: più ci penso, più mi piace, più mi emoziona. Libero il lettore di interpretare «il primo italiano» in senso cronologico, o in senso morale e spirituale. Perché Francesco è la nostra aspirazione al bene e al bello. Francesco è la parte migliore di noi.
tratto da «Francesco. Il primo italiano» di Aldo Cazzullo
Torna la festa dedicata a San Francesco
Il 4 ottobre del 2026 tornerà a essere la festa nazionale di San Francesco. È un’ipotesi che si sta concretizzando, alla luce di una proposta avanzata lo scorso anno ad Assisi dal poeta Davide Rondoni che attualmente ricopre l’incarico di presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte del santo.
Il 2026 sarà costellato di eventi dedicati a questa ricorrenza che vede già fiorire numerose iniziative. Gli anni appena trascorsi sono stati contraddistinti dalla memoria di altre tappe essenziali nella vita del povero di Assisi: il primo Presepe a Greccio, le Stimmate, la composizione del Cantico delle Creature.
Ci è data l’opportunità di vivere la tempesta molto tragica del presente sentendoci affiancati dalla presenza di un uomo santo, e Patrono d’Italia, che visse fino in fondo la prostrazione, e ne fece germogliare una voce di letizia. Questo è lo sfondo sostanziale di queste ricorrenze e anche il motivo per celebrare nuovamente una festa nazionale che esisteva ed è stata ridotta a festa civile nel 1977.
Dalla proposta di Rondoni si è arrivati a un provvedimento che è attualmente al vaglio del Governo (il 17 settembre si è votato alla Camera, poi si passerà alla valutazione del Senato) ed è frutto di due testi presentati da Maurizio Lupi (Noi moderati) e Lorenzo Malagola (Fratelli d’Italia). La relatrice alla Camera è stata Elisabetta Gardini (Fratelli d’Italia) che ha spiegato: «Si tratta di riconoscere che i valori incarnati da San Francesco, la pace, la fraternità, la solidarietà, la cura degli ultimi, il rispetto per la natura sono oggi più che mai necessari e sono valori che parlano a tutti, credenti e non credenti».
Non sarà una festività obbligatoria, ed è una precisazione su cui la Commissione Bilancio ha insistito per non gravare ulteriormente sulle casse degli istituti scolastici e sulle amministrazioni locali. L’invito, dunque, è quello di cogliere l’occasione della festa per favorire attività culturali, iniziative di approfondimento educativo che mettano a tema i valori di cui ha dato testimonianza san Francesco. Povertà, attenzione al creato, accoglienza dell’altro e pace. Sono temi, apparentemente, in perfetta sintonia con molte urgenze attuali.
Ma il santo di Assisi non fu semplicemente un ambientalista ante litteram e neppure un visionario romantico, per questo abbiamo chiesto a Davide Rondoni un affondo sul motivo autentico per cui è un segno essenziale che il nostro calendario sia dettato, anche, dal passo di Francesco.
Come presidente del Comitato san Francesco hai lanciato la proposta di ripristinare la festa nazionale del 4 ottobre. Qual è la situazione allo stato attuale?
Ho lanciato la proposta il 4 ottobre dell’anno scorso ad Assisi, sottolineando che il santo della pace, il santo dei malati, il santo che ci salvò dagli estremismi religiosi deve essere posto al centro dell’attenzione. Questo invito è stato ascoltato sia dalla premier Meloni sia dalle altre forze politiche che hanno messo in moto l’iter parlamentare per arrivare alla conclusione, in modo che il 4 ottobre del 2026 si possa celebrare definitivamente. Si è votato alla Camera, poi si passerà al Senato. Spero che non ci si divida su San Francesco.
Una possibile obiezione potrebbe essere sul fatto che la cronaca ci impone di inquadrare la nostra attualità come crivellata di guerre, di criticità drammatiche. Rispetto alle priorità ritenute imprescindibili, tirare fuori la parola «festa» potrebbe sembrare fuori luogo o di importanza molto secondaria. Perché abbiamo bisogno di questa celebrazione?
La festa dedicata a un santo ha proprio lo scopo di ricordarci che abbiamo dei patroni in cielo e non dei padroni sulla Terra. La povertà, tanto elogiata nella storia di Francesco, è riconoscere che non siamo i padroni nel mondo e non siamo i padroni di nessuno. Mai come adesso è urgente ricordarci di questo, che anche i signori della guerra non sono i padroni del mondo. Avere dei patroni in cielo aiuta a mettere a fuoco, a dire con chiarezza non solo che i grandi poteri fanno la guerra, ma che fanno la guerra nella vita delle persone, con l’alleanza di molte persone.
Nel sentire comune, il giorno di festa è un giorno in cui ci si ferma, ci si riposa. Possiamo intenderlo come un invito a fermarci, a riconsiderare che il tempo non è una nostra proprietà di cui abbuffarci e di cui spremere ogni secondo? Penso, banalmente, alle attività che sono aperte h 24 e 7 giorni su 7. Dobbiamo farci aiutare dai santi a scandire il tempo?
La festa è un segno offerto a chi vuole, ovviamente, non è obbligatoria. Si può festeggiare oppure no, ma è un segno. Più che sul tempo, insisterei proprio sul segno. Una civiltà che non lascia segni, lascia solo i marchi. È molto importante riaffermare il valore dei segni che san Francesco ha lasciato a tutta la civiltà europea. Sul tema, invece, del fermarci e della lentezza sono un po’ titubante. Riduciamo i termini della questione all’essere di corsa o andare lenti. Il punto non è se uno si ferma o non si ferma, ma a cosa guarda mentre va, e che ci siano dei segni mentre uno va rende migliore il cammino. Si può essere contemplativi anche di corsa.
Fonte: Tempi, settembre 2025
Padre Bruno 90
sabato 13 settembre 2025
"Al reverendo padre in Cristo, frate Crescenzio, per grazia di Dio ministro generale"
Al reverendo padre in Cristo, frate Crescenzio, per grazia di Dio ministro generale, frate Leone, frate Rufino e frate Angelo, che in passato furono compagni, senza esserne meritevoli, del beato padre Francesco, esprimono la loro doverosa e devota riverenza nel Signore.
573
Poiché per disposizione del Capitolo generale testè celebrato e vostra, i frati sono tenuti a comunicare alla paternità vostra i miracoli e i prodigi del beatissimo padre Francesco che essi conoscono o che possono reperire,
574
noi, che siamo vissuti più a lungo insieme con lui, malgrado non ne fossimo degni, abbiamo ritenuto opportuno di presentare alla santità vostra, guida la verità, alcune tra le molte gesta di lui, delle quali siamo stati spettatori o di cui abbiamo attinto notizie da altri santi frati. E specialmente da frate Filippo, visitatore delle Povere Dame, frate Illuminato dell'Arce, frate Masseo da Marignano e frate Giovanni, compagno del venerabile frate Egidio, che raccolse numerose informazioni sia da frate Egidio stesso che da frate Bernardo, di santa memoria, primo compagno del beato Francesco.
575
Non ci accontentiamo però di narrare solo dei miracoli, i quali palesano ma non fanno la santità; nostro intento è anche di mostrare alcuni aspetti salienti della sua santa vita e la intenzione della divina volontà, allo scopo di lodare e glorificare il sommo Dio e il santo padre Francesco, e di edificare quanti vogliono seguire i suoi esempi.
576
Non ci proponiamo tuttavia di scrivere una vita, dal momento che della sua vita e dei miracoli che Dio ha compiuto per mezzo di lui sono già state redatte delle <<leggende >>; bensì abbiamo colto, come da un prato rigoglioso, un mazzo di fiori, quelli che ci sono parsi i più belli, senza però disporli in ordine cronologico. E di proposito abbiamo tralasciato molti fatti, già raccontati in modo veridico ed elegante nelle leggende su ricordate: in esse voi potrete far inserire, se lo riterrete opportuno, questi nostri ricordi. Siamo invero persuasi che, se a quei valenti biografi fossero stati noti i presenti ricordi, non li avrebbero passati sotto silenzio; anzi, li avrebbero, almeno in parte, abbelliti con il loro stile, tramandandoli così alla memoria dei posteri.
577
Possa la santa paternità vostra stare sempre bene nel Signore Gesù Cristo; nel quale noi, figli devoti, ci raccomandiamo alla santità vostra con umiltà e devozione.
Dal luogo di Greccio, 11 agosto dell'anno del Signore 1246
L'importanza di questa lettera -- che si dichiara scritta da Greccio (11 agosto 1246) da tre compagni di Francesco, e precisamente Leone, Rufino e Angelo -- non è tale da fare passare in secondo ordine l'infinità di discussioni che ha sollevato. Soprattutto perché non risulta chiaramente, oggi, l'individuazione dei materiali biografici che i firmatari hanno inteso inviare << in allegato >>.
La lettera ci è stata tramandata, concordemente, in apertura della cosiddetta Leggenda dei tre compagni, a partire dalla fine del secolo XIII o inizio del XIV.
Essa palesa tuttavia un'evidente estraneità con una Leggenda che segue un andamento strettamente cronologico, aderendo alla trama della Vita prima di Tommaso da Celano, sia pure con diversità di toni e di dettati. Le intenzioni dichiarate dei compagni di Greccio erano di non scrivere una Vita di Francesco, bensì di portare un contributo nuovo, inedito, raccogliendo << come da un prato rigoglioso, un mazzo di fiori, quelli che ci sono parsi i più belli, senza però disporli in ordine cronologico >>. Il materiale inviato sembra, pertanto, doversi riconoscere, sostanzialmente, nella seconda parte della Vita seconda di Tommaso da Celano (1246/1247), a cui la raccolta -- intimata dal Capitolo Generale di Genova del 1244 e da Crescenzio da Iesi -- era destinata. Tale parte presenta, infatti, senza seguire alcun ordine cronologico, tutta una serie di fatti, gesti, volontà di Francesco che ben sembrano corrispondere alle intenzioni dei compagni di Greccio, anche se questo non significa che essa abbia incorporato tutta, o esclusivamente, la documentazione venuta da Greccio.
"Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese se non fossero come si addice alla santa povertà"
Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e uscii dal secolo.
E il Signore mi dette tale fede nelle chiese, che io così semplicemente pregavo e dicevo:
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa Chiesa romana, a motivo del loro ordine, che se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro.
E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà.
E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori. E non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché, dello stesso altissimo Figlio di Dio nient’altro vedo corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e il santissimo sangue suo, che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. E voglio che questi santissimi misteri sopra tutte le altre cose siano onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi. E i santissimi nomi e le parole di lui scritte, dovunque le troverò in luoghi indecenti, voglio raccoglierle, e prego che siano raccolte e collocate in luogo decoroso. E tutti i teologi e quelli che amministrano le santissime parole divine, dobbiamo onorarli e venerarli come coloro che ci amministrano lo spirito e la vita.
E dopo che il Signore mi dette dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. E io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor papa me la confermò. E quelli che venivano per intraprendere questa vita, distribuivano ai poveri tutto quello che potevano avere, ed erano contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle brache. E non volevamo avere di più. Noi chierici dicevamo l’ufficio, conforme agli altri chierici; i laici dicevano i Pater noster, e assai volentieri ci fermavamo nelle chiese. Ed eravamo illetterati e sottomessi a tutti.
E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare; e voglio fermamente che tutti gli altri frati lavorino di un lavoro quale si conviene all’onestà. E quelli che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro, ma per dare l’esempio e tener lontano l’ozio. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore, chiedendo l’elemosina di porta in porta.
Il Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: «Il Signore ti dia la pace!».
Si guardino bene i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e tutto quanto viene costruito per loro, se non fossero come si addice alla santa povertà, che abbiamo promesso nella Regola, sempre dimorandovi da ospiti come forestieri e pellegrini. Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che, dovunque si trovino, non osino chiedere lettera alcuna [di privilegio] nella Curia romana, né personalmente né per interposta persona, né a favore di chiesa o di altro luogo, né sotto il pretesto della predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi; ma, dovunque non saranno accolti, fuggano in altra terra a fare penitenza con la benedizione di Dio. E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità e ad altro guardiano che gli sarà piaciuto di assegnarmi. E così voglio essere prigioniero nelle sue mani, che io non possa andare o fare oltre l’obbedienza e la volontà sua, perché egli è mio signore. E sebbene sia semplice e infermo, tuttavia voglio sempre avere un chierico, che mi reciti l’ufficio, così come è prescritto nella Regola.
E tutti gli altri frati siano tenuti ad obbedire così ai loro guardiani e a dire l’ufficio secondo la Regola. E se si trovassero dei frati che non dicessero l’ufficio secondo la Regola, e volessero variarlo in altro modo, o non fossero cattolici, tutti i frati, ovunque sono, siano tenuti per obbedienza, ovunque trovassero qualcuno di essi, a farlo comparire davanti al custode più vicino al luogo dove l’avranno trovato. E il custode sia fermamente tenuto per obbedienza a custodirlo severamente, come un uomo in prigione giorno e notte, così che non possa essergli tolto di mano finché non lo consegni di persona nelle mani del suo ministro. E il ministro sia fermamente tenuto, per obbedienza, a mandarlo per mezzo di tali frati che lo custodiscano giorno e notte come un uomo imprigionato, finché non lo presentino davanti al signore di Ostia, che è signore, protettore e correttore di tutta la fraternità. E non dicano i frati: «Questa è un’altra Regola», perché questa è un ricordo, un’ammonizione, un’esortazione e il mio testamento, che io, frate Francesco piccolino, faccio a voi, fratelli miei benedetti, affinché osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al Signore.
E il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi siano tenuti, per obbedienza, a non aggiungere e a non togliere niente da queste parole. E sempre abbiano con sé questo scritto accanto alla Regola. E in tutti i capitoli che fanno, quando leggono la Regola, leggano anche queste parole.
E a tutti i miei frati, chierici e laici, comando fermamente, per obbedienza, che non inseriscano spiegazioni nella Regola né in queste parole dicendo: «Così devono essere intese»; ma come il Signore ha dato a me di dire e di scrivere con semplicità e purezza la Regola e queste parole, così voi con semplicità e senza commento cercate di comprenderle, e con santa operazione osservatele sino alla fine.
E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in cielo della benedizione dell’altissimo Padre, e in terra sia ricolmo della benedizione del suo Figlio diletto con il santissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. E io frate Francesco piccolino, vostro servo, per quel poco che posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima benedizione.
Testamento di San Francesco
lunedì 8 settembre 2025
"Itinerari francescani nelle Marche": 13 settembre 2025
domenica 10 agosto 2025
L'ultimo saluto al frate archeologo
venerdì 1 agosto 2025
Festa di Santa Chiara
sabato 26 luglio 2025
Ecco il progetto!
lunedì 30 giugno 2025
I cento anni della terziaria Maria Brecciaroli
sabato 26 aprile 2025
In quel nome, la scelta di un programma
In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre in una vita di felicità che non conoscerà tramonto. A nome del Collegio dei Cardinali ringrazio cordialmente tutti per la vostra presenza. Con intensità di sentimento rivolgo un deferente saluto e vivo ringraziamento ai Capi di Stato, ai Capi di Governo e alle Delegazioni ufficiali venute da numerosi Paesi ad esprimere affetto, venerazione e stima verso il Papa che ci ha lasciati.
Il plebiscito di manifestazioni di affetto e di partecipazione, che abbiamo visto in questi giorni dopo il suo passaggio da questa terra all’eternità, ci dice quanto l’intenso Pontificato di papa Francesco abbia toccato le menti ed i cuori. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella di domenica scorsa, Solennità di Pasqua, quando papa Francesco, nonostante i gravi problemi di salute, ha voluto impartirci la benedizione dal balcone della Basilica di San Pietro e poi è sceso in questa piazza per salutare dalla papamobile scoperta tutta la grande folla convenuta per la Messa di Pasqua. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l’anima dell’amato Pontefice a Dio, perché Gli conceda l’eterna felicità nell’orizzonte luminoso e glorioso del suo immenso amore. Ci illumina e ci guida la pagina del Vangelo, nella quale è risuonata la voce stessa di Cristo che interpellava il primo degli Apostoli: “Pietro, mi ami tu più di costoro?”. E la risposta di Pietro era stata pronta e sincera: “Signore, Tu conosci tutto; Tu sai che ti voglio bene!”. E Gesù gli affidò la grande missione: “Pasci le mie pecore”. Sarà questo il compito costante di Pietro e dei suoi Successori, un servizio di amore sulla scia del Maestro e Signore Cristo che “non era venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per tutti” (Mc.10,45).
Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all’ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge, la Chiesa di Dio, memore della frase di Gesù citata dall’Apostolo Paolo: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (Atti, 20,35). Quando il Card. Bergoglio, il 13 marzo del 2013, fu eletto dal Conclave a succedere a papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella Compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall’esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell’Arcidiocesi di Buenos Aires, prima come Ausiliare, poi come Coadiutore e in seguito, soprattutto, come Arcivescovo.
Filo conduttore della sua missione è stata anche la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti; una casa dalle porte sempre aperte. Ha più volte fatto ricorso all’immagine della Chiesa come “ospedale da campo” dopo una battaglia in cui vi sono stati molti feriti; una Chiesa desiderosa di prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone e dei grandi affanni che lacerano il mondo contemporaneo; una Chiesa capace di chinarsi su ogni uomo, al di là di ogni credo o condizione, curandone le ferite. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi.
Nel 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco ha firmato un documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune”, richiamando la comune paternità di Dio.
Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo, con la Lettera Enciclica Laudato si’ha richiamato l’attenzione sui doveri e sulla corresponsabilità nei riguardi della casa comune. “Nessuno si salva da solo”.
Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra – diceva – è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta.
Caro papa Francesco, ora chiediamo a Te di pregare per noi e che dal cielo Tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa Basilica in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l’umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza.
Omelia al funerale di Papa Francesco (26 aprile 2025)
ROGITO PER IL PIO TRANSITO
DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
MORTE, DEPOSIZIONE E TUMULAZIONE
DI FRANCESCO DI SANTA MEMORIA
Con noi pellegrino di speranza, guida e compagno di cammino verso la grande meta alla quale siamo chiamati, il Cielo, il 21 aprile dell’Anno Santo 2025, alle ore 7,35 del mattino, mentre la luce della Pasqua illuminava il secondo giorno dell’Ottava, Lunedì dell’Angelo, l’amato Pastore della Chiesa Francesco è passato da questo mondo al Padre. Tutta la Comunità cristiana, specialmente i poveri, rendeva lode a Dio per il dono del suo servizio reso con coraggio e fedeltà al Vangelo e alla mistica Sposa di Cristo.
Francesco è stato il 266° Papa. La sua memoria rimane nel cuore della Chiesa e dell’intera umanità.
Jorge Mario Bergoglio, eletto Papa il 13 marzo 2013, nacque a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, da emigranti piemontesi: suo padre Mario era ragioniere, impiegato nelle ferrovie, mentre sua madre, Regina Sivori, si occupava della casa e dell’educazione dei cinque figli. Diplomatosi come tecnico chimico, scelse poi la strada del sacerdozio entrando inizialmente nel seminario diocesano e, l’11 marzo 1958, passando al noviziato della Compagnia di Gesù. Fece gli studi umanistici in Cile e, tornato nel 1963 in Argentina, si laureò in filosofia al collegio San Giuseppe a San Miguel. Fu professore di letteratura e psicologia nei collegi dell’Immacolata di Santa Fé e in quello del Salvatore a Buenos Aires. Ricevette l’ordinazione sacerdotale il 13 dicembre 1969 dall’Arcivescovo Ramón José Castellano, mentre il 22 aprile 1973 emise la professione perpetua nei gesuiti. Dopo essere stato maestro di novizi a Villa Barilari a San Miguel, professore presso la facoltà di teologia, consultore della provincia della Compagnia di Gesù e rettore del Collegio, il 31 luglio 1973 fu nominato provinciale dei gesuiti dell’Argentina. Dopo il 1986 trascorse alcuni anni in Germania per ultimare la tesi dottorale e, una volta tornato in Argentina, il cardinale Antonio Quarracino lo volle suo stretto collaboratore. Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Scelse come motto episcopale Miserando atque eligendo e nello stemma inserì il cristogramma IHS, simbolo della Compagnia di Gesù. Il 3 giugno 1997, fu promosso Arcivescovo coadiutore di Buenos Aires e alla morte del cardinale Quarracino gli succedette, il 28 febbraio 1998, come Arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale residenti nel Paese, gran cancelliere dell’Università Cattolica. Giovanni Paolo II lo creò cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001, del titolo di san Roberto Bellarmino. Nel successivo ottobre fu relatore generale aggiunto alla decima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Fu un pastore semplice e molto amato nella sua Arcidiocesi, che girava in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus. Abitava in un appartamento e si preparava la cena da solo, perché si sentiva uno della gente.
Dai Cardinali riuniti in Conclave dopo la rinuncia di Benedetto XVI fu eletto Papa il 13 marzo 2013 e prese il nome di Francesco, perché sull’esempio del santo di Assisi volle avere a cuore innanzitutto i più poveri del mondo. Dalla loggia delle benedizioni si presentò con le parole «Fratelli e sorelle, buonasera! E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi». E, dopo aver chinato il capo, disse: «Vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo». Il 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, iniziò ufficialmente il suo ministero Petrino.
Sempre attento agli ultimi e agli scartati dalla società, Francesco appena eletto scelse di abitare nella Domus Sanctae Marthae, perché non poteva fare a meno del contatto con le persone, e sin dal primo Giovedì Santo volle celebrare la Messa in Coena Domini fuori dal Vaticano, recandosi ogni volta nelle carceri, in centri di accoglienza per i disabili o tossicodipendenti. Ai sacerdoti raccomandava di essere sempre pronti ad amministrare il sacramento della misericordia, ad avere il coraggio di uscire dalle sacrestie per andare in cerca della pecorella smarrita e di tenere aperte le porte della chiesa per accogliere quanti desiderosi dell’incontro con il Volto di Dio Padre.
Ha esercitato il ministero Petrino con instancabile dedizione a favore del dialogo con i musulmani e con i rappresentanti delle altre religioni, convocandoli talvolta in incontri di preghiera e firmando Dichiarazioni congiunte a favore della concordia tra gli appartenenti alle diverse fedi, come il Documento sulla fratellanza umana siglato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi con il leader sunnita al-Tayyeb. Il suo amore per gli ultimi, gli anziani e i piccoli lo spinse ad iniziare le Giornate Mondiali dei Poveri, dei Nonni e dei Bambini. Istituì anche la Domenica della Parola di Dio.
Più di ogni Predecessore ha allargato il Collegio dei Cardinali, convocando dieci Concistori nei quali ha creato 163 porporati, dei quali 133 elettori e 30 non elettori, provenienti da 73 nazioni, di cui 23 non avevano mai avuto prima un cardinale. Ha convocato 5 Assemblee del Sinodo dei Vescovi, 3 generali ordinarie, dedicate alla famiglia, ai giovani e alla sinodalità, una straordinaria ancora sulla famiglia, e una speciale per la Regione Panamazzonica.
Più volte la sua voce si è levata in difesa degli innocenti. Alla diffusione della pandemia da Covid-19, la sera del 27 marzo 2020 volle pregare da solo in piazza San Pietro, il cui colonnato simbolicamente abbracciava Roma e il mondo, per l’umanità impaurita e piagata dal morbo sconosciuto. Gli ultimi anni di pontificato sono stati costellati da numerosi appelli per la pace, contro la Terza guerra mondiale a pezzi in atto in vari Paesi, soprattutto in Ucraina, come pure in Palestina, Israele, Libano e Myanmar.
Dopo il ricovero del 4 luglio 2021, durato dieci giorni, per un intervento chirurgico presso il Policlinico Agostino Gemelli, Francesco il 14 febbraio 2025 si è recato nuovamente nello stesso ospedale per una degenza di 38 giorni, a causa di una polmonite bilaterale. Rientrato in Vaticano ha trascorso le ultime settimane di vita a Casa Santa Marta, dedicandosi fino alla fine e con la stessa passione al suo ministero petrino, seppure ancora non ristabilito del tutto. Nel giorno di Pasqua, il 20 aprile del 2025, per un’ultima volta si è affacciato dalla loggia della Basilica di San Pietro per impartire la solenne benedizione Urbi et Orbi.
Il magistero dottrinale di Papa Francesco è stato molto ricco. Testimone di uno stile sobrio e umile, fondato sull’apertura alla missionarietà, sul coraggio apostolico e sulla misericordia, attento nell’evitare il pericolo dell’autoreferenzialità e della mondanità spirituale nella Chiesa, il Pontefice propose il suo programma apostolico nell’esortazione Evangelii gaudium (24 novembre 2013). Tra i documenti principali si annoverano 4 Encicliche: Lumen fidei (29 giugno 2013) che affronta il tema della fede in Dio, Laudato si’ (24 maggio 2015) che tocca il problema dell’ecologia e la responsabilità del genere umano nella crisi climatica, Fratelli tutti (3 ottobre 2020) sulla fraternità umana e l’amicizia sociale, Dilexit nos (24 ottobre 2024) sulla devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù. Ha promulgato 7 Esortazioni apostoliche, 39 Costituzioni apostoliche, numerosissime Lettere apostoliche delle quali la maggioranza in forma di Motu Proprio, 2 Bolle di indizione degli Anni Santi, oltre alle Catechesi proposte nelle Udienze generali ed alle allocuzioni pronunciate in diverse parti del mondo. Dopo aver istituito le Segreterie per la Comunicazione e per l’Economia, e i Dicasteri per i Laici, la Famiglia e la Vita e per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Egli ha riformato la Curia romana emanando la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium (19 marzo 2022). Ha modificato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale nel CCEO e nel CIC (M.P. Mitis et misericors Iesus e Mitis Iudex Dominus Iesus) e ha reso più severa la legislazione riguardo i crimini commessi da rappresentanti del clero contro minori o persone vulnerabili (M.P. Vos estis lux mundi).
Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale.
CORPUS FRANCISCI P.M.
VIXIT ANNOS LXXXVIII, MENSES IV DIES IV.
ECCLESIAE UNIVERSAE PRAEFUIT
ANNOS XII MENSES I DIES VIII
Semper in Christo vivas, Pater Sancte!















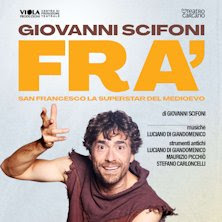







_page-0001%20(2).jpg)




