 |
| Voce della Vallesina, 17 novembre 2024 |
Quasi in sordina è circolata, nelle scorse settimane, la notizia della ristampa, a cura della casa editrice “La nave di Teseo”, del romanzo “Ladri di biciclette”, capolavoro di Luigi Bartolini, pubblicato per la prima volta nel 1946.
L’inguaribile ritrosia dei marchigiani rischia di sottovalutare la rilevanza dell’evento editoriale, con la conseguenza di lasciare in ombra il talento multiforme di questo figlio di Cupramontana, apprezzato per le eccelse qualità di incisore (tra i migliori del Novecento) e per le singolari doti di scrittore e poeta (“La sua prosa è crepitante, miracolosamente in bilico tra l’estro capriccioso e una sapiente classicità” Geno Pampaloni).
Non è facile individuare nella realtà artistica del secolo scorso, altro autore che possa uguagliare Luigi Bartolini (1892-1963) per varietà e mole di produzione. Ammontano ad oltre 1300 le lastre incise nel corso della sua attività, più di 80 sono i titoli dei suoi libri, cui si aggiungono un numero imprecisato di quadri e di saggi nelle maggiori riviste letterarie dell’epoca (“Fieramosca”, “Il Frontespizio”, “Il Selvaggio”).
“Ladri di biciclette”, all’inizio stampato in appena 150 copie, fu rieditato dalla Longanesi nel 1948 e dalla Vallecchi nel 1954. Nel corso degli anni, il testo ha raggiunto livelli di diffusione straordinari, come attestato da ben quindici traduzioni (persino in norvegese, svedese ed ebraico).
Non a caso, Valerio Volpini ebbe a definire “Ladri di biciclette” come uno dei romanzi “più riusciti e felici di questo dopoguerra”.
All’opera letteraria si ispirò (non senza vibranti contestazioni da parte dell’autore) la sceneggiatura dell’omonimo film di Vittorio de Sica, Premio Oscar nel 1954.
Il romanzo è ambientato a Roma nel settembre del 1944, a pochi mesi dall’avvenuta liberazione ad opera delle truppe del Generale Clark: il protagonista viene derubato del suo unico mezzo di locomozione, indispensabile per poter lavorare (“La bicicletta d’alluminio, bella, leggera, del peso di cinque chili, con i copertoni seminuovi, il manubrio da corsa, il portapacchi”).
Nell’attività di indagine per ritrovare il bene sottratto, Bartolini trascina il lettore nei quartieri malfamati della capitale (“Siamo nei paraggi di Campo de’ Fiori, covo d’antichi ladri e d’attuali, centuplicati. Via dei Baullari, via dei Coronari, vicolo del Cinque; lì sono i covi, le case, le osterie, i bar, le botteghe, i ripostigli, i bordelli, i ricettacoli dei ladri”): una sorta di girone infernale in cui vige suprema la legge del furto.
Di fronte a tale tragedia morale, Bartolini matura una personale forma di pietas laica, frammista ad elementi umoristici: “L’uomo è, del resto, ladro per natura. Esistono teorie politiche che ammettono il furto. Lo stesso San Francesco accenna, nella sua Regola, al seguente: si può, andando per campagne, togliere, a un albero, tanti fichi, o tanta uva, quanti fichi o uva entrino in un fardello. San Francesco dà anche la misura del fardello: che non deve superare quella d’uno zendale rimboccato”.
Nella visione bartoliniana, la ricerca ossessiva della bicicletta assume un valore esemplare per spiegare il senso autentico della vita: “Non si tratta, vivendo, che di ritrovare il perduto. Lo si può ritrovare una, due volte, tre, come io, per due volte sono riuscito a ritrovare la bicicletta. Ma verrà la terza volta e ritroverò più nulla. Così, è, ripeto tutta l’esistenza. E’ un correre a ritroso, per finalmente perdere o morire (…). Si cercan fin troppe cose prima di morire. Ed io cercherò un volto amico e troverò soltanto quello di Luciana, se lo troverò: che sarebbe, per i miei ultimi dolori, già un morire con il sole davanti agli occhi”.
Proprio in questi giorni l’amatissima figlia Luciana ha voluto donare al Comune di Jesi un’opera del padre (“Il bambino cinese”, olio su cartone del 1952), “a testimonianza del profondo legame che Bartolini ha sempre intrattenuto con l’atmosfera culturale di questi luoghi”.
In effetti, la formazione artistica di Luigi Bartolini ebbe inizio a Jesi con la frequenza della Scuola Tecnica (si diplomò nel 1907 con un dieci in disegno), per poi proseguire a Siena, Roma e Firenze e dispiegarsi, nella maturità, in tante città italiane.
Mai, tuttavia, si affievolirà la nostalgia per il paese natio (“La bella Cupreo. Cupreo in greco significa rame corrusco e, dunque, Cupramontana significa colle fiammeggiante”) e per i suoi fieri abitanti.
Mauro Torelli



pdf-3-cropped.jpg)







%20(1)_page-0001.jpg)

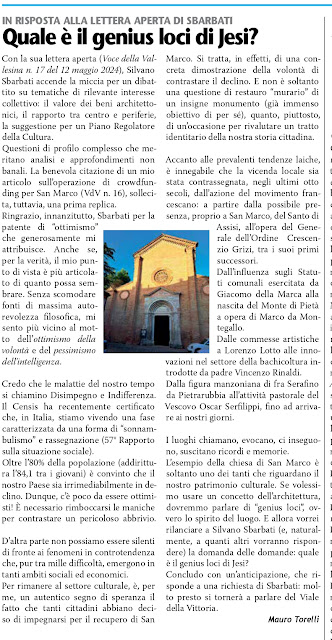


-5-cropped_page-0001.jpg)
-4-cropped_page-0001.jpg)





-1%20ESTRATTO-cropped_page-0001.jpg)




-2_page-0001.jpg)