In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre in una vita di felicità che non conoscerà tramonto. A nome del Collegio dei Cardinali ringrazio cordialmente tutti per la vostra presenza. Con intensità di sentimento rivolgo un deferente saluto e vivo ringraziamento ai Capi di Stato, ai Capi di Governo e alle Delegazioni ufficiali venute da numerosi Paesi ad esprimere affetto, venerazione e stima verso il Papa che ci ha lasciati.
Il plebiscito di manifestazioni di affetto e di partecipazione, che abbiamo visto in questi giorni dopo il suo passaggio da questa terra all’eternità, ci dice quanto l’intenso Pontificato di papa Francesco abbia toccato le menti ed i cuori. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella di domenica scorsa, Solennità di Pasqua, quando papa Francesco, nonostante i gravi problemi di salute, ha voluto impartirci la benedizione dal balcone della Basilica di San Pietro e poi è sceso in questa piazza per salutare dalla papamobile scoperta tutta la grande folla convenuta per la Messa di Pasqua. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l’anima dell’amato Pontefice a Dio, perché Gli conceda l’eterna felicità nell’orizzonte luminoso e glorioso del suo immenso amore. Ci illumina e ci guida la pagina del Vangelo, nella quale è risuonata la voce stessa di Cristo che interpellava il primo degli Apostoli: “Pietro, mi ami tu più di costoro?”. E la risposta di Pietro era stata pronta e sincera: “Signore, Tu conosci tutto; Tu sai che ti voglio bene!”. E Gesù gli affidò la grande missione: “Pasci le mie pecore”. Sarà questo il compito costante di Pietro e dei suoi Successori, un servizio di amore sulla scia del Maestro e Signore Cristo che “non era venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per tutti” (Mc.10,45).
Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all’ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon Pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge, la Chiesa di Dio, memore della frase di Gesù citata dall’Apostolo Paolo: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere” (Atti, 20,35). Quando il Card. Bergoglio, il 13 marzo del 2013, fu eletto dal Conclave a succedere a papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella Compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall’esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell’Arcidiocesi di Buenos Aires, prima come Ausiliare, poi come Coadiutore e in seguito, soprattutto, come Arcivescovo.
Filo conduttore della sua missione è stata anche la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti; una casa dalle porte sempre aperte. Ha più volte fatto ricorso all’immagine della Chiesa come “ospedale da campo” dopo una battaglia in cui vi sono stati molti feriti; una Chiesa desiderosa di prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone e dei grandi affanni che lacerano il mondo contemporaneo; una Chiesa capace di chinarsi su ogni uomo, al di là di ogni credo o condizione, curandone le ferite. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi.
Nel 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco ha firmato un documento sulla “Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune”, richiamando la comune paternità di Dio.
Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo, con la Lettera Enciclica Laudato si’ha richiamato l’attenzione sui doveri e sulla corresponsabilità nei riguardi della casa comune. “Nessuno si salva da solo”.
Di fronte all’infuriare delle tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, papa Francesco ha incessantemente elevata la sua voce implorando la pace e invitando alla ragionevolezza, all’onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra – diceva – è solo morte di persone, distruzioni di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente: essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta.
Caro papa Francesco, ora chiediamo a Te di pregare per noi e che dal cielo Tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa Basilica in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l’umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza.
Omelia al funerale di Papa Francesco (26 aprile 2025)
ROGITO PER IL PIO TRANSITO
DI SUA SANTITÀ FRANCESCO
MORTE, DEPOSIZIONE E TUMULAZIONE
DI FRANCESCO DI SANTA MEMORIA
Con noi pellegrino di speranza, guida e compagno di cammino verso la grande meta alla quale siamo chiamati, il Cielo, il 21 aprile dell’Anno Santo 2025, alle ore 7,35 del mattino, mentre la luce della Pasqua illuminava il secondo giorno dell’Ottava, Lunedì dell’Angelo, l’amato Pastore della Chiesa Francesco è passato da questo mondo al Padre. Tutta la Comunità cristiana, specialmente i poveri, rendeva lode a Dio per il dono del suo servizio reso con coraggio e fedeltà al Vangelo e alla mistica Sposa di Cristo.
Francesco è stato il 266° Papa. La sua memoria rimane nel cuore della Chiesa e dell’intera umanità.
Jorge Mario Bergoglio, eletto Papa il 13 marzo 2013, nacque a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, da emigranti piemontesi: suo padre Mario era ragioniere, impiegato nelle ferrovie, mentre sua madre, Regina Sivori, si occupava della casa e dell’educazione dei cinque figli. Diplomatosi come tecnico chimico, scelse poi la strada del sacerdozio entrando inizialmente nel seminario diocesano e, l’11 marzo 1958, passando al noviziato della Compagnia di Gesù. Fece gli studi umanistici in Cile e, tornato nel 1963 in Argentina, si laureò in filosofia al collegio San Giuseppe a San Miguel. Fu professore di letteratura e psicologia nei collegi dell’Immacolata di Santa Fé e in quello del Salvatore a Buenos Aires. Ricevette l’ordinazione sacerdotale il 13 dicembre 1969 dall’Arcivescovo Ramón José Castellano, mentre il 22 aprile 1973 emise la professione perpetua nei gesuiti. Dopo essere stato maestro di novizi a Villa Barilari a San Miguel, professore presso la facoltà di teologia, consultore della provincia della Compagnia di Gesù e rettore del Collegio, il 31 luglio 1973 fu nominato provinciale dei gesuiti dell’Argentina. Dopo il 1986 trascorse alcuni anni in Germania per ultimare la tesi dottorale e, una volta tornato in Argentina, il cardinale Antonio Quarracino lo volle suo stretto collaboratore. Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo nominò Vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Scelse come motto episcopale Miserando atque eligendo e nello stemma inserì il cristogramma IHS, simbolo della Compagnia di Gesù. Il 3 giugno 1997, fu promosso Arcivescovo coadiutore di Buenos Aires e alla morte del cardinale Quarracino gli succedette, il 28 febbraio 1998, come Arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale residenti nel Paese, gran cancelliere dell’Università Cattolica. Giovanni Paolo II lo creò cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001, del titolo di san Roberto Bellarmino. Nel successivo ottobre fu relatore generale aggiunto alla decima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
Fu un pastore semplice e molto amato nella sua Arcidiocesi, che girava in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus. Abitava in un appartamento e si preparava la cena da solo, perché si sentiva uno della gente.
Dai Cardinali riuniti in Conclave dopo la rinuncia di Benedetto XVI fu eletto Papa il 13 marzo 2013 e prese il nome di Francesco, perché sull’esempio del santo di Assisi volle avere a cuore innanzitutto i più poveri del mondo. Dalla loggia delle benedizioni si presentò con le parole «Fratelli e sorelle, buonasera! E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi». E, dopo aver chinato il capo, disse: «Vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo». Il 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, iniziò ufficialmente il suo ministero Petrino.
Sempre attento agli ultimi e agli scartati dalla società, Francesco appena eletto scelse di abitare nella Domus Sanctae Marthae, perché non poteva fare a meno del contatto con le persone, e sin dal primo Giovedì Santo volle celebrare la Messa in Coena Domini fuori dal Vaticano, recandosi ogni volta nelle carceri, in centri di accoglienza per i disabili o tossicodipendenti. Ai sacerdoti raccomandava di essere sempre pronti ad amministrare il sacramento della misericordia, ad avere il coraggio di uscire dalle sacrestie per andare in cerca della pecorella smarrita e di tenere aperte le porte della chiesa per accogliere quanti desiderosi dell’incontro con il Volto di Dio Padre.
Ha esercitato il ministero Petrino con instancabile dedizione a favore del dialogo con i musulmani e con i rappresentanti delle altre religioni, convocandoli talvolta in incontri di preghiera e firmando Dichiarazioni congiunte a favore della concordia tra gli appartenenti alle diverse fedi, come il Documento sulla fratellanza umana siglato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi con il leader sunnita al-Tayyeb. Il suo amore per gli ultimi, gli anziani e i piccoli lo spinse ad iniziare le Giornate Mondiali dei Poveri, dei Nonni e dei Bambini. Istituì anche la Domenica della Parola di Dio.
Più di ogni Predecessore ha allargato il Collegio dei Cardinali, convocando dieci Concistori nei quali ha creato 163 porporati, dei quali 133 elettori e 30 non elettori, provenienti da 73 nazioni, di cui 23 non avevano mai avuto prima un cardinale. Ha convocato 5 Assemblee del Sinodo dei Vescovi, 3 generali ordinarie, dedicate alla famiglia, ai giovani e alla sinodalità, una straordinaria ancora sulla famiglia, e una speciale per la Regione Panamazzonica.
Più volte la sua voce si è levata in difesa degli innocenti. Alla diffusione della pandemia da Covid-19, la sera del 27 marzo 2020 volle pregare da solo in piazza San Pietro, il cui colonnato simbolicamente abbracciava Roma e il mondo, per l’umanità impaurita e piagata dal morbo sconosciuto. Gli ultimi anni di pontificato sono stati costellati da numerosi appelli per la pace, contro la Terza guerra mondiale a pezzi in atto in vari Paesi, soprattutto in Ucraina, come pure in Palestina, Israele, Libano e Myanmar.
Dopo il ricovero del 4 luglio 2021, durato dieci giorni, per un intervento chirurgico presso il Policlinico Agostino Gemelli, Francesco il 14 febbraio 2025 si è recato nuovamente nello stesso ospedale per una degenza di 38 giorni, a causa di una polmonite bilaterale. Rientrato in Vaticano ha trascorso le ultime settimane di vita a Casa Santa Marta, dedicandosi fino alla fine e con la stessa passione al suo ministero petrino, seppure ancora non ristabilito del tutto. Nel giorno di Pasqua, il 20 aprile del 2025, per un’ultima volta si è affacciato dalla loggia della Basilica di San Pietro per impartire la solenne benedizione Urbi et Orbi.
Il magistero dottrinale di Papa Francesco è stato molto ricco. Testimone di uno stile sobrio e umile, fondato sull’apertura alla missionarietà, sul coraggio apostolico e sulla misericordia, attento nell’evitare il pericolo dell’autoreferenzialità e della mondanità spirituale nella Chiesa, il Pontefice propose il suo programma apostolico nell’esortazione Evangelii gaudium (24 novembre 2013). Tra i documenti principali si annoverano 4 Encicliche: Lumen fidei (29 giugno 2013) che affronta il tema della fede in Dio, Laudato si’ (24 maggio 2015) che tocca il problema dell’ecologia e la responsabilità del genere umano nella crisi climatica, Fratelli tutti (3 ottobre 2020) sulla fraternità umana e l’amicizia sociale, Dilexit nos (24 ottobre 2024) sulla devozione al Sacratissimo Cuore di Gesù. Ha promulgato 7 Esortazioni apostoliche, 39 Costituzioni apostoliche, numerosissime Lettere apostoliche delle quali la maggioranza in forma di Motu Proprio, 2 Bolle di indizione degli Anni Santi, oltre alle Catechesi proposte nelle Udienze generali ed alle allocuzioni pronunciate in diverse parti del mondo. Dopo aver istituito le Segreterie per la Comunicazione e per l’Economia, e i Dicasteri per i Laici, la Famiglia e la Vita e per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Egli ha riformato la Curia romana emanando la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium (19 marzo 2022). Ha modificato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale nel CCEO e nel CIC (M.P. Mitis et misericors Iesus e Mitis Iudex Dominus Iesus) e ha reso più severa la legislazione riguardo i crimini commessi da rappresentanti del clero contro minori o persone vulnerabili (M.P. Vos estis lux mundi).
Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale.
CORPUS FRANCISCI P.M.
VIXIT ANNOS LXXXVIII, MENSES IV DIES IV.
ECCLESIAE UNIVERSAE PRAEFUIT
ANNOS XII MENSES I DIES VIII
Semper in Christo vivas, Pater Sancte!

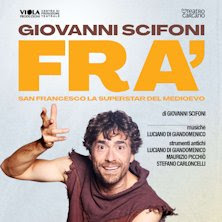







_page-0001%20(2).jpg)



